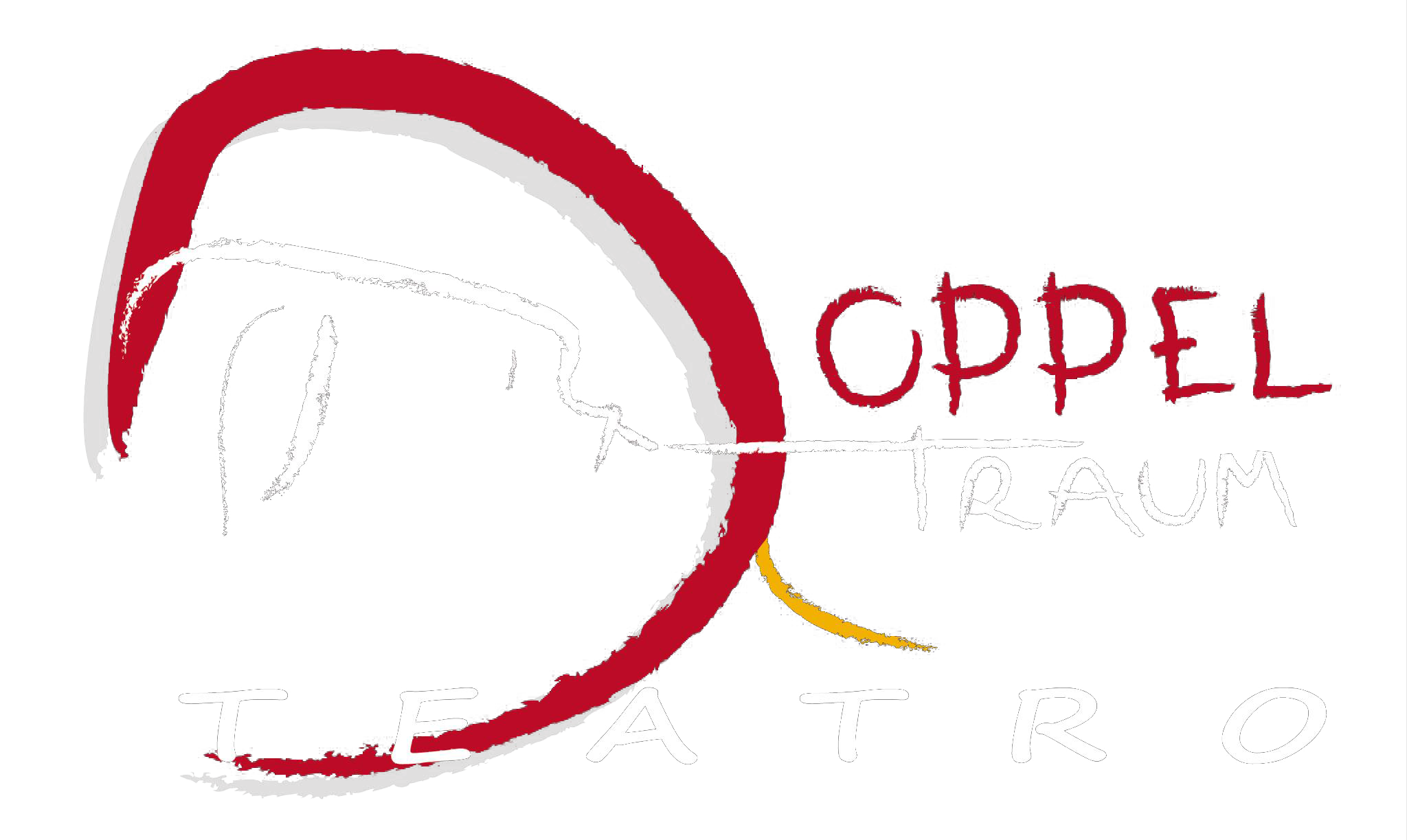DUE ATTI DI DISSENSO
“La firma” di Václav Havel // “L’attestato” di Pavel Kohout
LA FIRMA
di Václav Havel
regia di Chiara Bosco
con Federico Palumeri e Flavio Vigna
elementi di scena Maurizio Fò
L’ATTESTATO
di Pavel Kohout
regia di Federico Palumeri
con Chiara Bosco, Luana Doni, Maurizio Fò, Cristina Renda, Flavio Vigna
elementi di scena Maurizio Fò
una produzione Doppeltraum Teatro con il sostegno dell’Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini e con il patrocinio della Città di Torino
Nell’ambito delle celebrazioni del cinquantenario del Sessantotto e in vista del trentennale della caduta del Muro di Berlino, presso il Polo del ‘900 di Torino, l’Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini, in collaborazione con la compagnia teatrale Doppeltraum Teatro, ha intrapreso la produzione di uno spettacolo tratto da due tra le più famose voci del dissenso della drammaturgia contemporanea cecoslovacca: Václav Havel e Pavel Kohout.
Due atti unici scritti per essere rappresentati insieme, uno stesso tema: il dissidente, il mondo che lo circonda, i conflitti morali della Cecoslovacchia dopo la Primavera di Praga.
Due atti unici, due autori pericolosi per il regime: Havel e Kohout, grandi drammaturghi che con questo lavoro avrebbero voluto cominciare una collaborazione, spezzata dall’incarcerazione del primo e dall’espulsione del secondo. Due ritratti del dissenso che ci restituiscono una società intimorita e “normalizzata”, che rifiuta i dissidenti poiché ne avverte la distanza morale che li separa da coloro che alla scelta hanno preferito il compromesso. Due atti che ci interrogano sul ruolo dell’artista e dell’intellettuale, sulle sue responsabilità civili di fronte al pericolo, sempre in agguato, della passività sociale.
La messa in scena, caratterizzata da un impianto sobrio, quasi scarno e astratto, si sviluppa intorno alla centralità della parola degli attori. Ne La firma l’atmosfera plumbea della Cecoslovacchia normalizzata permea un interno soffocante e carico di allusioni, non detti, silenzi che si sviluppano tra i due personaggi: Stanek, un intellettuale che ha abbandonato la militanza politica in favore di una vita agiata caratterizzata dal costante compromesso con i poteri forti; e Vanek, quasi un alter ego di Havel, uno scrittore che ha pagato la propria integrità morale con il carcere e l’alienazione dal mondo del teatro. Il protagonista (che ritorna nel secondo atto) è un “principio drammatico”: sulla scena non fa quasi nulla, eppure il solo fatto di essere ciò che è costringe chi gli sta intorno a manifestarsi e a motivare se stessi. Ecco che il dialogo tra i due diventa quindi specchio dell’effettiva incapacità di comunicazione tra i due mondi di appartenenza.
Nella messa in scena, quasi non c’è più Praga, la sua Primavera, il regime sovietico, bensì un grigiore diffuso, uno smarrimento morale e culturale di struggente attualità: un mondo di compromessi, di sottili perfidie della sorte, un muro di gomma che assorbe qualsiasi tentativo di resistenza culturale e che quasi schernisce l’agire di chi, nonostante le repressioni, racconta una storia diversa. E non riesce a comunicare, in prima istanza, nemmeno con chi potrebbe considerare un proprio simile. Un testo lucido e lineare, una rappresentazione non filologica nell’ambientazione ma estremamente fedele negli intenti di chi ha pensato il testo quando il mondo poneva chiaramente il dilemma sul posizionamento sociale dell’arte e dei suoi operatori.
Ne L’attestato l’atmosfera cambia solo apparentemente. L’ambiente è l’interno di un ufficio pubblico di registrazione di animali domestici popolato da personaggi anch’essi grigi: impiegati integrati loro malgrado in un sistema di gerarchie quasi comiche – la presenza della giovane figlia di un dirigente di partito genera una buffa sottomissione da parte del personale – maschere di una società intimorita dalle conseguenze del seppur minimo gesto di trasgressione delle regole. Come nei migliori testi di teatro dell’assurdo, il catalizzatore drammaturgico è il cane di Vanek, che non si vede mai, ma che gode di maggiore attenzione di quella riservata al suo proprietario. Il microcosmo dell’ufficio diventa specchio della diffidenza della società nei confronti del dissidente, della paura, della “mansuetudine del popolo ceco” che sembra incapace di uscire dall’impasse di una burocrazia alienata. Il solo modo di salvarsi, suggerisce Kohout, è affidarsi alle giovani generazioni (incarnate nella giovane “raccomandata”), più libere e inconsapevoli e, forse per questo, più trasgressive. Più collocato storicamente nella Cecoslovacchia degli anni Settanta, il testo di Kohout è una commedia capace di divertire con amarezza, risolvendosi inevitabilmente in un “nulla di fatto”, risvolto tragicomico dell’immobilismo dell’atto di Havel.